Settembre 1991.
La guerra in Croazia è una realtà, dalla Krajina alla Slavonia.
Dal 19 agosto ogni dubbio è stato spazzato via con l’assedio di Vukovar, città strategica sulla sponda croata del Danubio [puoi recuperare qui l’ultimo episodio di BarBalcani - Podcast].
Belgrado può fare affidamento sia sull’Armata Popolare Jugoslava (JNA) sia sugli squadroni paramilitari, contro una Guardia Nazionale ormai allo sbando.
Ma la brutalità dimostrata dai serbi ad agosto ha smosso le coscienze a Bruxelles. I Dodici della Comunità Europea (CEE) si sono espressi contro il governo federale.
Si tenta una via per la pace.
Ma Belgrado sa bene come muoversi sul terreno del doppio gioco.
Un piano di (non) pace
La premessa di ogni discorso è che sui Balcani non ci sono i presupposti per la pace.
Il primo settembre, nonostante la tregua del giorno precedente, Petrinja viene bombardata dai MiG e conquistata dai carri armati della JNA.
La regione della Baranja - nella Slavonia Orientale - è parte della Grande Serbia.
In ogni caso, la Comunità Europea decide di dare avvio a una conferenza, presieduta dal conservatore britannico Lord Peter Carrington.
La Conferenza sul futuro della Jugoslavia e dei suoi popoli si apre il 7 settembre all’Aja, con l’ambizioso obiettivo di garantire la pace entro due mesi.
Al tavolo delle trattative ci sono i membri della Presidenza collettiva jugoslava, il governo federale, i presidenti delle sei Repubbliche, i ministri degli Esteri dei Dodici e il presidente del Consiglio d’Europa.
Si parte dall’interpretazione che l’aggressione serba in Croazia è parte di una guerra civile, in cui i contendenti hanno ragione e torto in misura uguale.
Se ne deduce che la questione non può essere risolta con cambiamenti di frontiera violenti e che nessuna Repubblica può aspirare alla sovranità senza un accordo fra tutte e sei.
Si parla anche della questione bosniaca. La proposta è di creare tre Repubbliche per permettere ai serbi di collegarsi a Belgrado e ai croati a Zagabria. Ma i Dodici si oppongono alla possibile nascita di uno Stato musulmano nei Balcani.
Dopo cinque giorni di negoziati, il 12 settembre viene firmata una Dichiarazione d’intenti.
Dai documenti spicca l’impegno a rispettare i diritti delle minoranze e a non ricorrere alla violenza per ottenere cambiamenti di confine.
Promesse contraddette dai fatti.
E non solo in Croazia.
Il giorno successivo all’avvio dei lavori all’Aja, nella Repubblica Socialista di Macedonia si svolge un referendum sull’indipendenza, sulla falsariga di quello sloveno e di quello croato.
L’8 settembre il 95,26% dei votanti si esprime per la separazione dalla Repubblica Socialista Federale (affluenza oltre il 75%).
Il 25 settembre viene dichiarata l’indipendenza.
Kiro Gligorov è il primo presidente democraticamente eletto della Repubblica di Macedonia.
Ma, in questo caso, non si registra nessuna resistenza da parte di Belgrado. Nella Grande Serbia non ci sono lembi di terra macedone, perciò le relazioni con Skopje possono rimanere buone e con un reciproco riconoscimento.
Al contrario - ironia della sorte - proprio nel giorno della firma della Dichiarazione dell’Aja le operazioni belliche si estendono nel territorio della Repubblica Socialista di Bosnia ed Erzegovina per la prima volta.
Sulla frontiera meridionale con la Croazia, a una trentina di chilometri da Ragusa, la città di Trebinje cade in mano serba il 12 settembre.
È lo scossone che serve al presidente bosniaco, Alija Izetbegović, per superare l’idea che «scegliere tra Tuđman e Milošević è come optare tra leucemia e tumore al cervello».
Ora è chiaro che il piano messo in pratica in Croazia sta per replicarsi anche in Bosnia ed Erzegovina.
Le milizie locali si ingrossano con l’arrivo di riservisti serbi e montenegrini, ma soprattutto con le unità paramilitari. In particolare le Tigri di Arkan e la Guardia Nazionale di Vuk Drašković, lungo la loro marcia su Dubrovnik.
Il 16 settembre, sulla scorta delle esperienze in Croazia, viene proclamata la Regione Autonoma della Krajina bosniaca, «parte indivisibile della Jugoslavia federale».
All’Aja Izetbegović ottiene solo la promessa che gli osservatori internazionali saranno inviati anche in Bosnia.
Doppio gioco a Belgrado
A dire il vero, a Belgrado c’è qualcuno che denuncia il Piano Ram per la creazione della Grande Serbia.
È Stipe Mesić, il presidente della Jugoslavia. L’ultimo che ancora crede di poter fermare l’Armata e il presidente serbo, Slobodan Milošević.
Il suo è un tentativo disperato. Senza consultare i colleghi della Presidenza collettiva, l’11 settembre intima al capo delle Forze armate, Veljko Kadijević, di ritirare le truppe.
La risposta è beffarda: il presidente federale dovrebbe sapere che le competenze di comandante supremo spettano alla Presidenza nella sua collettività.
Intanto la Caporetto della mediazione europea arriva al suo culmine.
I serbi conquistano due punti nevralgici. A nord, l’autostrada Belgrado-Zagabria tra Okučani e Nova Gradiška. A sud, il ponte di Maslenica presso Zara.
Vengono tagliate le comunicazioni della capitale croata con la Dalmazia e la Slavonia.
Il presidente croato, Franjo Tuđman, reagisce dando seguito all’ultimatum di fine agosto.
Il 14 settembre ordina il blocco delle caserme federali e taglia loro ogni approvvigionamento, assicurando alla Guardia Nazionale armi e munizioni.
Una settimana dopo si gettano le basi per una difesa più organica del territorio, con la creazione dello Stato maggiore dell’esercito.
Ma sui campi di battaglia iniziano a comparire anche le unità paramilitari croate: le Zebre, le Legioni nere e l’Associazione di difesa croata.
Tra i 10 e i 15 mila uomini con l’uniforme nera degli ustascia (i fascisti croati), che al pari dei “colleghi” serbi si macchiano di atrocità soprattutto sui civili.
Di fronte all’escalation di violenza il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dichiara che la Jugoslavia è «una minaccia per la pace internazionale».
Il 25 settembre viene approvata all’unanimità la Risoluzione 713. Sulla Jugoslavia cade la scure del «generale e totale embargo su tutte le forniture di armi e materiale bellico».
È la mossa Kansas City del governo serbo.
Nella mossa Kansas City, la vittima della truffa si aspetta di essere imbrogliata e si crede talmente furba da poter individuare da dove arriverà la mossa del carnefice.
In un posto sperduto della provincia marchigiana, viene anche chiamata “la trappoletta de Mario”. Quando la vittima pensa addirittura che il carnefice abbia sbagliato mossa e di averlo incastrato.
E invece era già tutto previsto.
Ecco cosa succede a Belgrado. Forse per la prima volta nella storia, un Paese accoglie favorevolmente una misura punitiva contro se stesso.
La Risoluzione 713 congela il possesso di armi delle parti in guerra. Nei fatti favorisce la Serbia, che ha il controllo dell’esercito federale e dell’industria bellica.
Alla Croazia e alle Repubbliche contrarie all’egemonismo serbo viene negato il diritto all’autodifesa, sancito dall’articolo 51 della Carta dell’ONU.
Sul campo di battaglia il doppio gioco di Belgrado dà i risultati sperati.
Da Osijek partono i rinforzi per l’assedio di Vukovar, mentre in Dalmazia scatta l’assedio di Dubrovnik. A niente vale la protezione dell’UNESCO della “Perla dell’Adriatico”.
C’è anche tempo per sbarazzarsi dell’ingombrante presenza di Mesić, che aveva cercato di salvare Dubrovnik con lettere all’ONU, agli Stati Uniti e ai governi di mezza Europa.
In una seduta a cui non può presenziare, il 25 settembre (ancora una volta le date si sovrappongono) i rappresentanti di Serbia, Montenegro, Kosovo e Vojvodina in seno alla Presidenza collettiva lo defenestrano.
Il vice-presidente, il montenegrino Branko Kostić, approva la revoca del mandato di Mesić come rappresentante all’Assemblea ONU.
In più, aboliscono la norma costituzionale che imponeva alla Presidenza federale di prendere decisioni a maggioranza assoluta. Ora vale quella dei presenti che - guarda caso - possono riunirsi solo a Belgrado per lo stato di emergenza.
La Presidenza collettiva assume anche le funzioni del Parlamento.
Bruxelles ne ha abbastanza. I Dodici annunciano che non riconosceranno le decisioni di un’assemblea che non rappresenta più l’intera Federazione.
Implicitamente stanno ammettendo la scomparsa della Jugoslavia.
Ti è piaciuto questo articolo? Amplifica la voce del nostro percorso parallelo e della newsletter settimanale gratuita sui social:
Altrimenti puoi regalare un abbonamento a chi vuoi. Non lasciare che si perda questo viaggio virtuale sui Balcani!
Qui l’archivio di BarBalcani - Podcast:





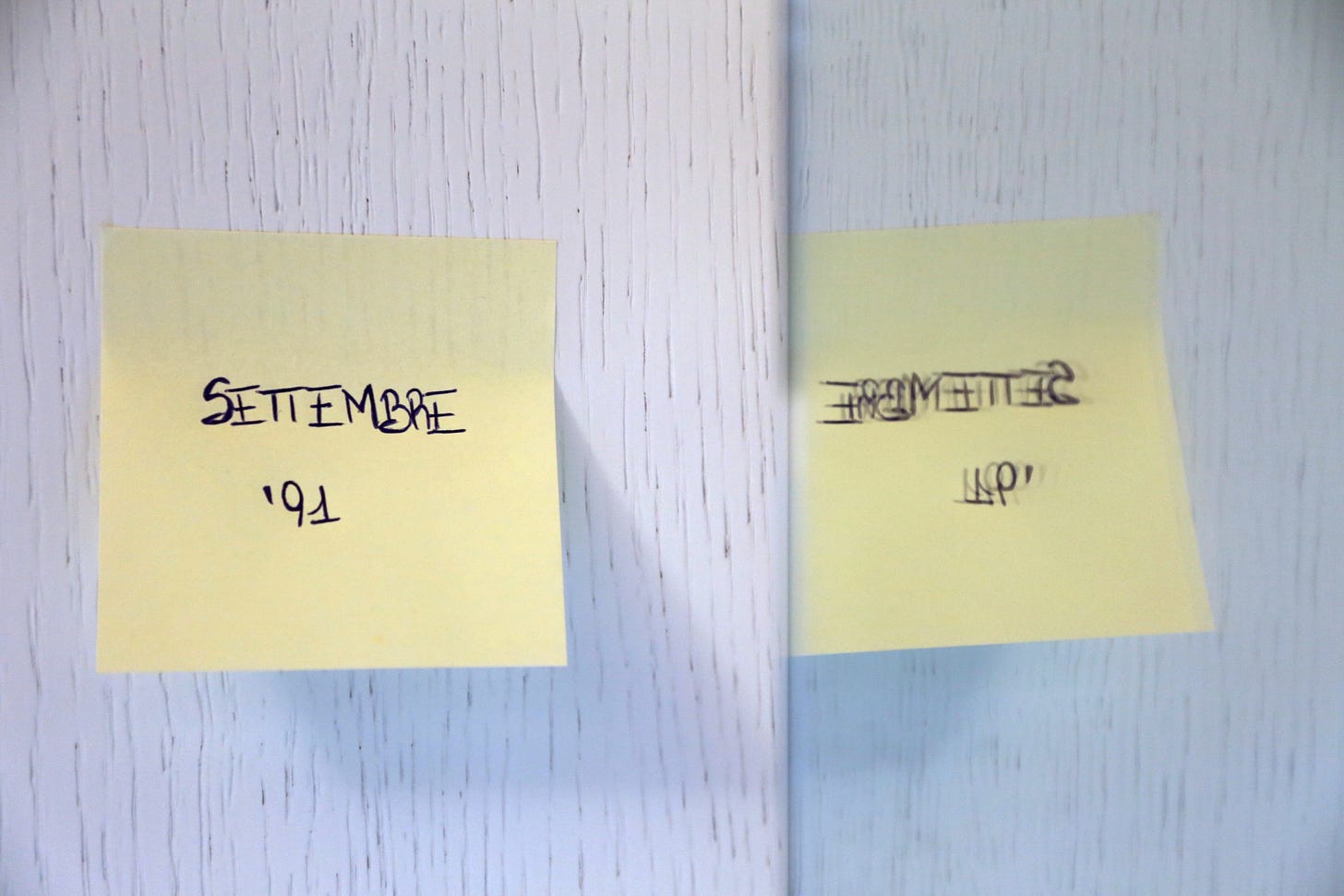



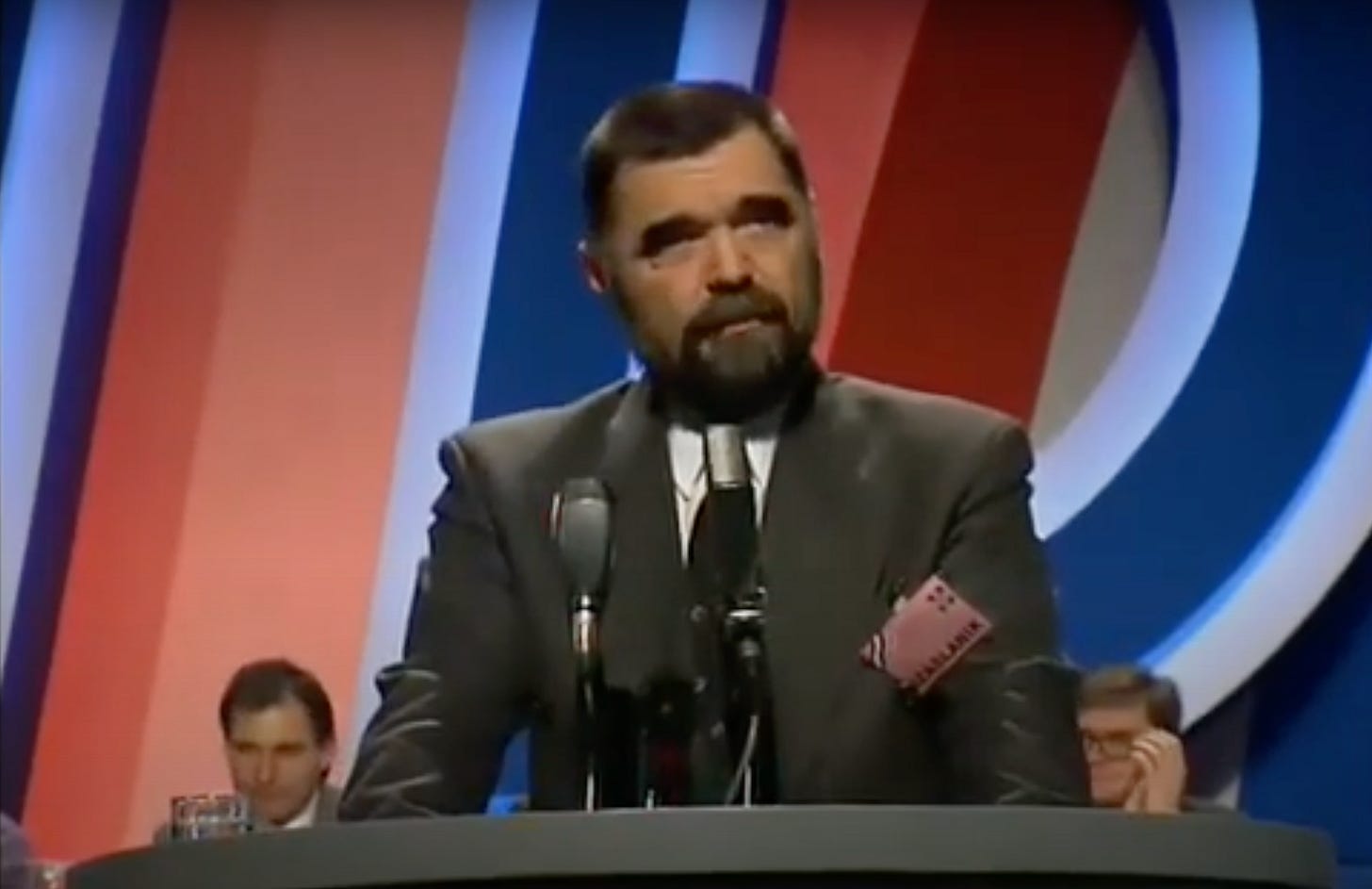





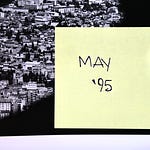
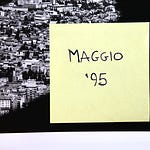


Share this post